Quando ero studente all’estero, mi esibivo regolarmente come pianista jazz. E ho ricevuto molti apprezzamenti. Mi piace pensare che era dovuto alla mia musicalità, ma c’era qualcos’altro che contribuiva al mio “successo”.
Nei circoli jazz, ero chiaramente un americano. E tutti sanno che il grande jazz viene dagli Stati Uniti—proprio come gli orologi eleganti arrivano dalla Svizzera e il formaggio dalla Francia. Ero autentico per il luogo di origine e l’evidente accento yankee. E questo mi ha dato una certa distinzione sulla scena jazz all’estero.
Mi è piaciuto molto.
Così sono stato assunto e riassunto. Tutti mi hanno sorriso. Quando presentavano la band, l’annunciatore si assicurava sempre di dire: Per favore, accogliete al pianoforte—direttamente da Los Angeles, California—Ted Gioia!”
Applaudivano un po’ più forte a quella risposta. All’epoca tutti amavano Los Angeles. Ok, forse non ero una star di Hollywood, ma ho avuto un piccolo assaggio di cosa fosse davvero il glamour di La La Land.
Ma quando sono tornato qualche anno dopo, tutto era cambiato.
Non ricevevo più quella affettuosità. Nessuno si è nemmeno più preso la briga di menzionare la mia origine americana—non gliene importava affatto. È stato come scoprire che il formaggio puzzolente è davvero puzzolente.
Qualcosa era cambiato nel jazz europeo. Ai musicisti lì non importava minimamente di quello che succedeva a Los Angeles o New York. Non più. Invece parlavano solo della loro scena jazz entusiasmante e dei musicisti autoctoni.
E avevano molto di cui parlare.
Il jazz europeo era cresciuto, e non invidiavano più noi americani. Il povero Ted è stato escluso senza pietà.
E sapevo chi incolpare. Era quel dannato norvegese, Jan Garbarek.

Certo, c’erano altri da incolpare—non aveva fatto tutto da solo. Ma Garbarek era il capo e il modello di riferimento. Ha mostrato com’era il jazz europeo orgoglioso e sicuro di sé—senza scuse e indipendente dalle tendenze e dalle aspettative provenienti dagli Stati Uniti. E dopo Garbarek, non c’era più ritorno. Non avrei mai più gustato quel sapore di glamour yankee.
Ma probabilmente non dovrei biasimare Garbarek e tutti gli altri europei. Era grande—e, ancora più che grande, aveva creato un suono formidabile tutto suo, liberato dalle influenze statunitensi. Il risultato è stato scatenare una nuova atmosfera pro-Europa che si diffuse presto in tutto il continente.
Anche io adoravo ascoltare queste cose, nonostante il prezzo personale che avevo pagato. Cos’altro potevo fare?

Ovviamente Garbarek non era sempre stato così indipendente e distaccato dalle correnti statunitensi.
Una volta ho sentito un nastro bootleg di Jan Garbarek che suonava in età adolescenziale. Non potevo credere a quello che sentivo. Suonava hot hard bop come se fosse nato a Philadelphia o New York.
L’ho sempre associato al jazz da camera europeo, completamente disconnesso dall’attrazione gravitazionale degli stili postbop statunitensi. Ma ora è chiaro che le sue ispirazioni originali non erano molto diverse dalle mie. Non solo rispettava i modelli americani, ma aveva iniziato imparando a suonare i loro modi più idiomatici.
Questo è evidente nel suo primo album, una registrazione raramente ascoltata chiamata Til Vigdis. Racconta due esibizioni dal vivo e rivela un Garbarek profondamente immerso nella fraseologia tarda di Coltrane. La traccia d’apertura è una composizione di Coltrane, e per diciotto minuti Garbarek trasforma il suo strumento in una macchina a movimento perpetuo, accompagnato solo da basso e batteria.

Se cerchi il futuro leader del jazz da camera nordico, qui non è ancora evidente. Solo nell’ultima traccia, “Til Vigdis”, Garbarek lascia spazio e aria alle sue improvvisazioni, ma anche qui si percepisce la sua fedeltà ai modelli del free jazz statunitense.
Due anni dopo, Garbarek realizzò un altro album, Esoteric Circle, e qui i suoi stati d’animo riflessivi a volte attenuavano le sue tendenze ribelli. Ma questa è comunque musica intensa in cui la tonalità viene sempre spinta in modi poco convenzionali.
Qui Garbarek è affiancato dal chitarrista Terje Rypdal, dal bassista Arild Andersen e dal batterista Jon Christensen—tutti presto migrati all’etichetta ECM, e due di loro si uniranno poi al quartetto di Keith Jarrett, tanto amato dal pubblico. Ma non indovineresti mai tutto questo in un blindful test basandoti su questo primo album.
Meno di un anno dopo quel gruppo ha realizzato un disco per il produttore Manfred Eicher alla ECM, e è successo qualcosa di magico. L’album si chiama Afric Pepperbird—e Garbarek mostra ancora la sua fedeltà all’avanguardia, ma il suo tono ora è cambiato. Il suono inquietante e lamentoso che sarebbe stato il suo marchio di fabbrica nei decenni a venire ora si mostra in tutta la sua bellezza solitaria.

Questo giovane sassofonista, appena ventitreenne, è ancora affascinato da John Coltrane e da altri modelli statunitensi (in particolare l’iconoclasta Albert Ayler). Ma questo nuovo suono è qualcosa di diverso, qualcosa di nordico, qualcosa di originale. Non fu facile, nel 1970, per un musicista jazz europeo creare uno stile che non suonasse come un omaggio ai predecessori americani, ma Garbarek era ormai sulla strada giusta per farlo.
In una splendida congiunzione, il nuovo produttore discografico di Garbarek, Manfred Eicher, stava plasmando una visione simile: un’etichetta discografica jazz europea che non imitasse i suoi concorrenti statunitensi. Eicher è ormai una leggenda nel mondo del jazz, ma nel 1970 non era nemmeno un arrivista—solo un completo sconosciuto, un bassista che aveva lanciato ECM solo pochi mesi prima.
Negli anni successivi, Eicher produsse album storici di Keith Jarrett, Pat Metheny, Chick Corea e altre star del jazz. Ancora più importante, contribuì a lanciare le carriere di circa cento artisti jazz europei. Ma tutto questo era scritto nel futuro, quando entrò in studio con Jan Garbarek. Afric Pepperbird fu il settimo album per ECM, e nessuno dei suoi predecessori aveva avuto vendite particolarmente positive.
Così sono stato assunto e riassunto. Tutti mi hanno sorriso. Quando presentavano la band, l’annunciatore si assicurava sempre di dire: Per favore, accogliete al pianoforte—direttamente da Los Angeles, California—Ted Gioia!”
Eicher riportò Garbarek in studio per un nuovo album solo sette mesi dopo. E l’opera risultante, Triptykon, non solo rivela la crescente maturità del sassofonista, ma inizia anche a definire quello che sarebbe diventato noto come il suono ECM.
Alcuni lo descrivono come “chamber jazz”. E posso capire il perché. È musica più sfumata, suonata a volume più basso rispetto al jazz americano. Per questo motivo, è ben adatta alle stesse sale da concerto che ospitano quartetti d’archi e recital pianistici. È musica per chi ascolta attentamente invece di litigare al bar.

Qualcosa era cambiato nel jazz europeo. Ai musicisti lì non importava minimamente di quello che succedeva a Los Angeles o New York. Non più. Invece parlavano solo della loro scena jazz entusiasmante e dei musicisti autoctoni.
Noto che questa è una scelta molto appropriata per un’etichetta jazz tedesca come ECM. Il mondo di lingua tedesca ha praticamente inventato la musica da camera, e le sue aspettative culturali devono essere sembrate naturali per qualcuno come Eicher—in un modo che non sarebbe stato possibile per chi è cresciuto suonando blues in un juke joint del Mississippi o in un bordello di New Orleans.
L’Europa è davvero diversa. Quindi il jazz europeo dovrebbe riflettere questo.
Ma a un altro livello, la definizione di “musica da camera” per ECM, e in particolare per Garbarek, è fuorviante. Suggerisce una sorta di delicatezza pignola che è esattamente l’opposto delle declamazioni travolgenti del sassofonista sul suo strumento. Ecco perché Garbarek è così efficace nel suonare brani quasi-rock (soprattutto quando è in coppia con il chitarrista Rypdal): suona sempre con intensità, anche se nel suo caso non significa sempre forte o appariscente.
Ma ECM merita credito per un’altra innovazione: la nascita di un atteggiamento veramente globale e transfrontaliero verso il jazz. Non è insolito che Eicher presenti una band con ogni membro di un paese diverso—o addirittura di un continente diverso, come accadde quando Garbarek registrò con il brasiliano Egberto Gismonti e l’americano Charlie Haden. La stessa cosa accadde quando il sassofonista registrò con John Abercrombie e Naná Vasconcelos.
Questa apertura transfrontaliera fu una rivelazione per il mondo jazz degli anni ’70. Questa scelta ha aperto il terreno per Garbarek per registrare ECM con il cantante Ustad Fateh Ali Khan, Anouar Brahem o l’Hilliard Ensemble. Queste incursioni mettevano in discussione la stessa definizione di cosa sia il jazz—e nel modo migliore possibile.
Tutte queste correnti iniziano a unirsi nelle registrazioni di Garbarek della metà degli anni ’70—come la sottovalutata Red Lanta con il pianista Art Lande (1973), Dansere con il pianista Bobo Stenson (1976) e Dis con il chitarrista Ralph Towner (1976). Ognuna di queste è una dichiarazione importante sia per il musicista che per l’etichetta ECM. Garbarek ha ora trovato il suo ritmo e riesce a tenere il pubblico ipnotizzatop, non richiedendo più tutte le dimostrazioni alla Coltrane della sua giovinezza.

Basta ascoltare lo spazio, le note trattenute e la frase netta di “Lokk” di Dansere. Questa è una dichiarazione di indipendenza da tutti quei sapori incentrati sugli Stati Uniti (free, fusion, post-bop, ecc.) dell’epoca. Questo rappresentava un modo completamente nuovo di suonare il jazz, come anche gli americani stavano ora rendendosi conto.

Uno di quegli americani era Keith Jarrett. E presto pubblicò l’album solista di pianoforte di maggior successo della storia, The Köln Concert, per l’etichetta ECM. Ma pochi mesi prima di quel momento storico, Jarrett volò a Oslo, in Norvegia, per realizzare un album con la band di Garbarek.
Molti ne rimasero perplessi. Keith Jarrett aveva già un quartetto negli Stati Uniti, e molti appassionati di jazz pensavano fosse la migliore band del mondo. Perché doveva abbandonarla per tre scandinavi sconosciuti?

Ma l’album risultante, Belonging, registrato nell’arco di due giorni nell’aprile 1974, era destinato a diventare un cult. Considerate il fatto che Branford Marsalis ha pubblicato un album completo tributo a Belonging nel 2025, eseguendo ogni brano del disco con la sua band.

Anche le pop star prestavano attenzione a Belonging—tanto che Steely Dan fu citato in giudizio da Jarrett per violazione del copyright perché la title track di Gaucho suona così tanto simile a “Long as You Know You’re Living Yours” di Belonging. Jarrett aveva un argomento solido e alla fine fu aggiunto come co-compositore alla canzone degli Steely Dan.

Garbarek apparteneva davvero a Belonging perché sapeva adattarsi a ogni svolta della scrittura immaginativa di Jarrett. Poteva suonare in modo funky, folk o libero a seconda della situazione. Ma, anche qui, il suo tono nordico è il principale motivo di attrazione, quasi come il richiamo di un amante da una torre di un castello in una storia magica, che coinvolge profondamente l’ascoltatore nella musica.
Jarrett era così affascinato dal suo nuovo collaboratore che realizzò un altro album, Luminessence (1975), con Garbarek come unico solista, accompagnato dagli archi. Jarrett stesso non si esibisce nell’album—questa è una vera vetrina per il sassofonista. Jarrett compose tre opere, e si capisce quanto sia ossessionato dal tono schietto e malinconico di Garbarek.
“Ha studiato la musica di Jan,” spiegò poi il produttore Manfred Eicher, e l’intero album fu composto pensando a “Jan.” Questo sarebbe stato un complimento per Garbarek in ogni circostanza, ma soprattutto da Keith Jarrett—che di solito si aspetta che i musicisti si adattino a lui, non il contrario.
Jarrett proseguì con un altro album orchestrale, Arbour Zena—la sua opera più impressionante fino ad allora come compositore classico. Questa volta Keith suonò il pianoforte, ma ancora una volta presentò anche Garbarek. A quel punto, Jarrett era già una vera star della musica con un vasto pubblico mainstream grazie al suo enorme successo crossover The Köln Concert, e sembrava determinato a portare con sé il suo collaboratore norvegese in questo viaggio.

Jarrett era ora in tournée con la sua band nordica e si esibiva in sale da concerto con il tutto esaurito. Alcune registrazioni dal vivo furono poi pubblicate, ma il quartetto realizzò solo un altro album in studio—anche se è uno degli album jazz più celebrati del decennio.
Per molti fan questa registrazione, My Song, ha chiarito perché Jarrett si è unito a una band europea. Quindi non esagero quando dico che questo fu, in una certa misura, un momento di legittimazione per il jazz al di là della sfera della colonizzazione culturale americana.

Le cose erano cambiate. Quindi non sono rimasto davvero sorpreso che Garbarek continuasse a prosperare—sia creativamente che commercialmente—dopo la fine della sua collaborazione con Jarrett. Credo che questo fosse il suo destino.
Se il jazz americano aveva ancora una fissazione per New York—dimostrata in migliaia di album con musicisti che vivono tutti nella stessa città—Garbarek incarnava una possibilità diversa. Era l’uomo cosmopolita del mondo che trovava partner musicali ovunque, registrando dischi con Eleni Karaindrou, Ustad Bade Fateh Ali Khan, Naná Vasconcelos, Miroslav Vitouš, l’Ensemble Hilliard, Anouar Brahem, Rainer Brüninghaus, L. Shankar e molti altri provenienti da ogni parte.
Basta leggere i nomi nella sua discografia per farti un’idea di quanto sia diverso e ampio.
Ma altrettanto importante lo stile musicale unico di Garbarek dichiararono anche l’indipendenza dal timbro di approvazione “Made in America” che aveva precedentemente dominato tutte le esibizioni jazz. La generazione precedente ha visto grandi star del jazz europeo — George Shearing, Marian McPartland, Toots Thielemans, ecc. — trasferirsi negli Stati Uniti per raggiungere il livello successivo della loro carriera. Le loro carriere richiesero un trasferimento transatlantico. Dopo Garbarek, non era più necessario.
Ha aperto la strada che ha reso possibile la successiva emersione di tanti altri musicisti che sono rimasti vicini a casa, e che hanno comunque trovato legittimazione e celebrità—da EST a tutti quei nomi più caldi del Nu Jazz sulla scena londinese di oggi. Ognuno di loro dovrebbe ringraziare Jan Garbarek.
Garbarek ha dimostrato questa fertile indipendenza album dopo album dopo la sua uscita dal quartetto di Jarrett. Suona con tale autorità che le tracce migliori suonano come affermazioni profetiche di qualcuno appena tornato dalla cima della montagna. Ascoltalo, per esempio, in “Soria Maria” con Abercrombie e Vasconcelos.

O sentirlo in “Going Places”, dove il dinamismo della batteria Jack DeJohnette cerca di dare un calcio nel sedere nordico di Jan, ma Garbarek non cede. Continua a pronunciare il suo suono, nordico e solitario anche mentre il batterista americano triplica il ritmo del sassofono—fino a smettere intorno al terzo minuto. Poi anche DeJohnette decide di fluttuare al ritmo di un fiordo.

È come una metafora per tutta la carriera di Garbarek. La sua serenità al sax scorre in superficie, ma è solido come un ghiacciaio sottostante. Ed è lo stesso in ogni contesto—c’è di nuovo quella fiducia europea che mi ha tolto tutti i vantaggi.
Ma Garbarek, nonostante la sua durezza da ghiacciaio, stava ancora crescendo. Il suo lavoro più audace inizia intorno ai suoi cinquant’anni. A questo punto, non ha nemmeno più bisogno del jazz—almeno non in senso convenzionale. Ora è cittadino di paesaggi sonori universali con un passaporto che gli permette di viaggiare ovunque e in qualsiasi momento.

Consideriamo Ragas and Sagas, pubblicato nel 1992. Ecco la formazione della band
- Jan Garbarek suona il sax tenore e il soprano
- Ustad Fateh Ali Khan, pakistano, canta
- La norvegese (di discendenza punjabi/pashtun) Deepika Thathaal canta
- Ustad Nazim, pakistano, suona il sarangi
- Ustad Shaukat Hussain, pakistano,suona la tabla
- Manu Katché, francese—che ha registrato con Sting e Peter Gabriel—suona la batteria
Questa non è una jazz band. O forse lo è—ma solo nella mente vasta, che rompe i confini, di Jan Garbarek. Si integra sicuramente. O ancor di più, sembra destinato a suonare musica di questo tipo.
Nessuno di noi non se ne è reso conto finché non abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo.

Due anni dopo, Garbarek pubblicò un album in trio insieme al suonatore di oud tunisino Anouar Brahem e al pakistano Ustad Shaukat Hussai, alle tabla. Brahem ha scritto la maggior parte della musica, e Garbarek la interpreta con la stessa autorevolezza con cui ha suonato tutte quelle composizioni di Keith Jarrett vent’anni prima.

Più o meno nello stesso periodo, Garbarek intraprese la collaborazione più ambiziosa di questa fase finale della sua carriera—e la più insolita di tutte. Iniziò quindi a fare musica con l’Hilliard Ensemble, un celebre ensemble vocale britannico noto soprattutto per la musica medievale e del primo Rinascimento.
Amo questo gruppo, ma il suo miglior lavoro presenta musica liturgica composta cinquecento anni fa. A cosa potrebbe servire un sassofonista jazz? Ma si riunirono in un monastero austriaco e si lanciarono nel grande passo.
Come dimostrò Garbarek, entrambi operavano su una lunghezza d’onda inquietante in cui gli aggettivi moderno e medievale non sono più rilevanti. Ora tutto è senza tempo. La musica dell’album risultante, Officium, è sconvolgente, ma anche totalmente inadatta al formato di qualsiasi stazione radio.
Un ascoltatore, cercando di trovare un modo per descrivere quest’opera, si è espresso così: Officium è “ciò che Coltrane sente in paradiso.”

Il ritmo di registrazione di Garbarek rallentò notevolmente dopo il 2000. I suoi nuovi album divennero ormai rarità. Ma continuò a collaborare con l’Hilliard Ensemble fino allo scioglimento nel 2014. Non credo sia esagerato dire che questa è la musica più personale della sua carriera tarda—e anche la più mistica.
Forse tutti i musicisti jazz cercano la trascendenza, ma Garbarek sembra averla trovata—e, ancora meglio, vuole condividerla con noi altri ascoltatori. Dobbiamo solo essere disposti ad ascoltare. E anche mettere da parte tutte i nostri preconcetti sul sassofono, il jazz, le definizioni di genere e la cronologia storica.
Quindi continuerò a lamentarmi della perdita del dominio incontestato dell’America sull’idioma jazz. Mi è piaciuto ricevere quel trattamento speciale quando suonavo in Europa, ma (sospiro!) è sparito per sempre. Eppure, Garbarek mi ha ripagato completamente mostrando cosa significa una visione davvero ampia del jazz.
No, non ha portato via nulla a noi musicisti jazz americani. Ci ha davvero dato un dono—mostrandoci possibilità nelle nostre tradizioni che nemmeno sapevamo esistessero.
Chissà? Forse è proprio questo che dovrebbe fare il jazz.
Non ricevevo più quelle cure tenere e affettuose. Nessuno si è nemmeno preso la briga di menzionare la mia origine a Los Angeles—non gliene importava affatto. È stato come scoprire che il formaggio puzzolente è davvero puzzolente.
E avevano molto di cui parlare.
Il jazz europeo era cresciuto, e non invidiavano più noi americani. Il povero Ted è stato escluso dal freddo.
E sapevo a chi incolpare. Era quel dannato norvegese Jan Garbarek.
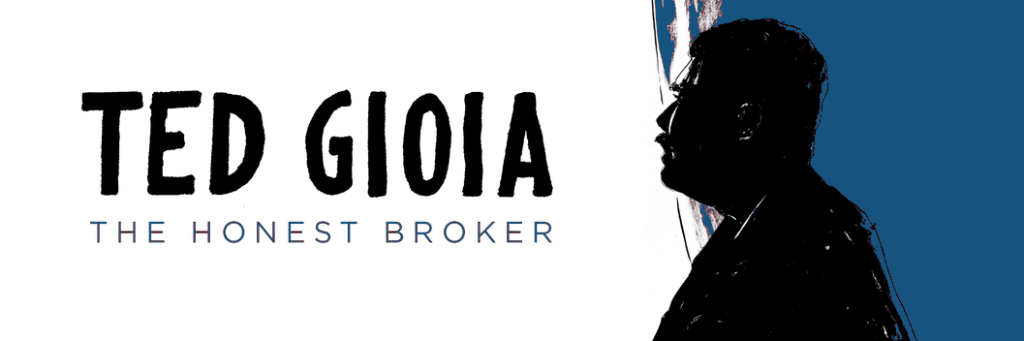



Bell’articolo e interessante, purtroppo non e non apprezzo né Garbarek e nemmeno Jarret; so bene di essere in solitaria, tuttavia questo jazz “da camera” come viene definito, è a capo della melassa europea che proprio la casa editrice ECM ci propone da decenni. Ho sempre ritenuto il jazz una musica intelligente ma graffiante, mancando uno di questi elementi viene meno lo spirito jazzistico. john Coltrane, il povero Albert Ayler, Ornette Coleman, Anthony Braxton fino a Ivo Perelman hanno segnato un percorso indelebile sullo sviluppo di questa grande musica. Da noi Europa furono Derek Bailey e Zimmerman, giusto x citate i primi due che mi vengono in mente che proseguirono quella strada statunitense contaminandola con la musica “contemporanea” di stampo classico europea.
Altro che melassa! 😁
"Mi piace"Piace a 1 persona
Petsonalmente, pur apprezzando moltissimo Garbarek, prediligo da sempre il jazz più sanguigno, quello nero americano, e per rimanere ai protagonisti di oggi citerei Threadgill, JB Lewis, Redman, Akinmusire, e i migliori tra gli americani non di colore Evans, Lloyd, Mehldau, Mazurek ecc.ecc..Sulla ECM da sempre si discute tra gli appassionati, e spesso ascoltando le nuove uscite le critiche trovano terreno fertile. Rimane però indiscutibile, almeno a mio parere, la qualità eccelsa del quartetto europeo di Jarrett.Non a caso lo scorso anno Brandford Marsalis ed il suo quartetto hanno riproposto per intero Belongin, celebre album del gruppo di Jarrett.
"Mi piace""Mi piace"
“purtroppo non apprezzo né Garbarek e nemmeno Jarret; so bene di essere in solitaria”. Tranquillo, siamo almeno in due. Mi spiego meglio: su Jarrett sospendo ogni giudizio – ed anche ogni ascolto – sino a quando non si sarà dissipato l’asfissiante ed acritico culto della personalità che lo circonda. Non riesco a staccarmi dall’idea che il primo motivo della popolarità di Jarrett vada ricercato nella sua accettazione nell’ambito della tradizione accademica europea, critica e pubblico inclusi (che entrambi ho felicemente salutato anni fa dopo lunga frequentazione). Il jazz non ha bisogno di patenti di accettabilità artistica rilasciate da chicchessia, il suo status di musica d’arte se lo è conquistato sul campo affrontando condizioni ed ambienti più che ostili, del tutto ignoti alla musica accademica europea. La quale dopo il 1950 non ha prodotto niente di nemmeno paragonabile a ‘Black Brown and Beige’ di Ellington, di ‘Kind of Blue’ di Davis o di ‘A Love Supreme’ di Coltrane. E veniamo ad ECM. E’ un caso di studio più unico che raro, una etichetta che a lungo andare ha creato un suo pubblico: in qualche raro negozio di dischi vedo ‘scaffali ECM’ che la inquadrano come genere musicale a sè stante, sic!. L’unico lato positivo che vedo nell’etichetta bavarese di oggi è la diligenza con cui promuove ed appoggia i suoi musicisti nel dissestato circuito concertistico di oggi. E’ vero che essa offre un approdo professionale di tutto prestigio ai suoi artisti, ma al prezzo di imporre loro un pesante ‘filtro di produzione’ che li allinea all’estetica – o meglio alla ‘maniera’ – ECM. Non a caso le loro performances dal vivo suonano notevolmente diverse. Altro serio punto critico. il catalogo ECM degli anni ’70 ed ’80 comprende opere di rilievo ormai storico che non vengono quasi mai ristampata in base ad un filosofia del ‘never look back’: estremamente opinabile quando ci si trova a gestire un oggettivo patrimonio culturale. Forse è scomodo il confronto tra la linea di allora ed il credo di oggi? 😉 Milton56
"Mi piace"Piace a 1 persona